|
|
|
| |
 |
Ritorna alla Home Page "Territorio" |
|
 |
|
|
Tre sono i
momenti principali in cui può essere suddiviso il processo di
formazione dei rilievi montuosi e del paesaggio in genere: il
tempo in cui si generano le rocce, il tempo del loro sollevamento
a formare le montagne e infine il tempo dell'erosione e del
modellamento del paesaggio. |
|
|
È probabile
che per turisti appassionati di montagna e di natura, che non
abbiano studiato geologia, possa essere alquanto difficile capire
i meccanismi naturali che portano alla formazione delle rocce,
delle montagne e del paesaggio. Vi sono antichi ed errati
pregiudizi, spesso alimentati da libri, giornali, riviste e
programmi televisivi. Soprattutto manca la nozione del tempo
geologico e della sua immensità, quindi della successione
temporale dei grandi eventi naturali. Così i dinosauri convivono
con gli uomini dell'«età della pietra» e vengono considerati
ammali preistorici, oppure la formazione di una montagna o di una
profonda gola viene imputata a «cataclismi», «sconvolgimenti» o
«catastrofi naturali». La storia della Terra viene commisurata con
la nostra vita e con la storia dell'umanità, tutto viene compresso
in poche migliaia di anni.
In questa prima parte del libro cercherò quindi di inserire il
lettore nel tempo dilatato del mondo geologico e introdurrò, nel
modo più semplice possibile, concetti e nozioni che ritengo
essenziali per poter meglio capire la storia geologica della
penisola italiana.
Questa storia può essere suddivisa, idealmente, in tre fasi o
momenti geologici in larga parte indipendenti. Essi sono, in
ordine cronologico, il tempo della formazione delle rocce
(litogenesi), il tempo della formazione delle montagne (orogenesi)
e quello della formazione del paesaggio e delle sue varie forme
(morfogenesi). |
|
1.1 |
Litogenesi: la formazione
delle rocce |
|
|
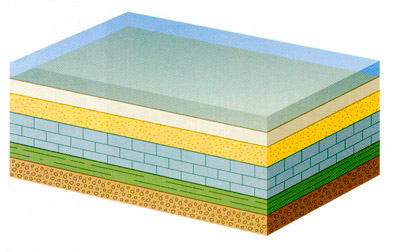 Cerchiamo di
capire meglio questi concetti pensando, per semplificare, ad
alcune famose montagne o regioni italiane quali, ad esempio, il
Monte Bianco, la Marmolada, le Alpi Apuane, il Gran Sasso,
l'Argentario, l'isola di Capri o il Gargano. Queste montagne sono
innanzitutto costituite di materiali, di rocce. E queste rocce,
come vedremo più avanti, si sono formate decine o centinaia di
milioni di anni fa, spesso accumulandosi sotto forma di sabbie,
limi e fanghiglie sul fondo di mari ora scomparsi oppure, come il
granito, si sono consolidate nel sottosuolo, a diversi kilometri
di profondità. Queste informazioni le ricaviamo dalla regolare
sovrapposizione degli strati, dalla presenza di conchiglie
pietrificate o dalla natura chimico-mineralogica delle rocce. Cerchiamo di
capire meglio questi concetti pensando, per semplificare, ad
alcune famose montagne o regioni italiane quali, ad esempio, il
Monte Bianco, la Marmolada, le Alpi Apuane, il Gran Sasso,
l'Argentario, l'isola di Capri o il Gargano. Queste montagne sono
innanzitutto costituite di materiali, di rocce. E queste rocce,
come vedremo più avanti, si sono formate decine o centinaia di
milioni di anni fa, spesso accumulandosi sotto forma di sabbie,
limi e fanghiglie sul fondo di mari ora scomparsi oppure, come il
granito, si sono consolidate nel sottosuolo, a diversi kilometri
di profondità. Queste informazioni le ricaviamo dalla regolare
sovrapposizione degli strati, dalla presenza di conchiglie
pietrificate o dalla natura chimico-mineralogica delle rocce.
Per quanto riguarda le rocce presenti nei monti dell'Italia, i
geologi sanno ormai con certezza che esse si sono formate in vari
momenti della storia del nostro pianeta: le più vecchie si trovano
in Sardegna e hanno dai 600 ai 400 milioni di anni, le più giovani
si trovano ai margini della catena appenninica e hanno al massimo
qualche milione di anni. Questo è dunque il periodo del processo
litogenetico (dal greco lithos = pietra), cioè della formazione
delle rocce.
|
|
1.2 |
Orogenesi: la formazione
delle montagne |
|
|
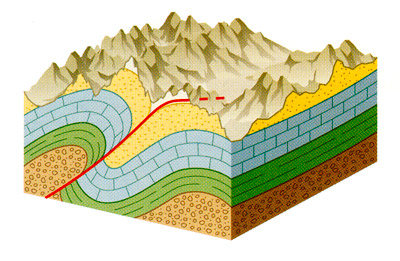 Ora però le
rocce stratificate di cui abbiamo appena parlato non si trovano
più sul fondo del mare e così pure il granito non è sepolto nella
crosta terrestre. Esse costituiscono massicci montuosi, cime,
isole, picchi o coste dirupate, spesso a centinaia o migliaia di
metri sul livello del mare. E di frequente non sono
disposte orizzontalmente, strato su strato, come in origine; sono
inclinate, piegate, addirittura contorte. Ecco
quindi che è necessario ammettere l'esistenza di un altro
meccanismo o processo che sia stato in grado di sollevare tali
materiali dal fondo degli antichi mari ormai scomparsi o di
riesumare la roccia granitica dal profondo sottosuolo,
sollevandoli alle quote delle montagne di oggigiorno. Ora però le
rocce stratificate di cui abbiamo appena parlato non si trovano
più sul fondo del mare e così pure il granito non è sepolto nella
crosta terrestre. Esse costituiscono massicci montuosi, cime,
isole, picchi o coste dirupate, spesso a centinaia o migliaia di
metri sul livello del mare. E di frequente non sono
disposte orizzontalmente, strato su strato, come in origine; sono
inclinate, piegate, addirittura contorte. Ecco
quindi che è necessario ammettere l'esistenza di un altro
meccanismo o processo che sia stato in grado di sollevare tali
materiali dal fondo degli antichi mari ormai scomparsi o di
riesumare la roccia granitica dal profondo sottosuolo,
sollevandoli alle quote delle montagne di oggigiorno.
Uno potrebbe obiettare: quei materiali non si sono affatto
sollevati, è stato il mare che si è ritirato, che si è abbassato
lasciando allo scoperto le rocce con i fossili marini. Si può
rispondere facilmente a questa obiezione rilevando quanto segue:
le rocce che formano le montagne sono, come già detto, piegate,
rotte, variamente contorte e queste deformazioni non possono
certamente essere indotte dal semplice ritiro dell'acqua; se
quanto detto a proposito del ritiro dell'acqua ha un qualche
aggancio logico per le rocce con fossili marini, certamente non
vale per il granito e per le rocce simili che derivano dal
raffreddamento e consolidamento di un magma ve-rificatisi a più
kilometri di profondità; da ultimo, occorre dire che, fin dal
tempo della loro formazione, 3n-4 miliardi di anni fa, il livello
dei mari non ha mai avuto oscillazioni superiori ad alcune
centinaia di metri. Non c'è abbastanza acqua (o vapore) sulla
Terra e nella circostante atmosfera per innalzare i mari di 2 -f-
3 km. Durante l'ultima più importante glaciazione, il mare si è
abbassato di circa 120 metri e nel periodo Cretaceo, circa cento
milioni di anni fa, un periodo caratterizzato dal massimo livello
dei mari (l'unica volta che il mare invase il deserto del Sahara
negli ultimi duecento milioni di anni), l'innalzamento fu
all'incirca di 250 -f 300 m.
Quindi, quando si legge o si sente dire che c'è l'«Arca di Noè»
sul Monte Ararat, a più di 5000 m di altezza, ricordiamoci che si
tratta di una storia senza alcun fondamento scientifico. L'acqua
del mare, infatti, a quelle quote non c'è mai stata: bisognerebbe
coprire tutta la Terra con uno strato di acqua alto 5-HO km, il
che equivarrebbe a triplicare la massa idrica (oceani, mari,
laghi, fiumi, ghiacciai, nubi) esistente attualmente sulla Terra.
E tutto questo in poche migliaia di anni.
Per tornare al fenomeno responsabile del sollevamento e del
piegamento dei vari materiali rocciosi, un processo assai
complesso, lungo e lentissimo che viene chiamato orogenesi (dal
greco oros = monte), possiamo dire che esso è il risultato di
eventi geologici a scala molto grande, più in particolare è
causato dalla collisione, dallo scontro dei grandi blocchi
continentali (Africa, India, Australia, Europa, Asia, ecc.) che
vanno alla deriva sulla superficie della Terra, come grandi
zattere. Le Alpi, gli Appennini e tutti i monti che costituiscono
l'Italia, dalla Sicilia alla Svizzera, e molte altre catene
montuose dell'area mediterranea, quali quelle di Grecia, Albania,
Croazia, Tunisia, Algeria, Spagna meridionale, ecc., devono la
loro genesi, più o meno direttamente, al continuo e progressivo
avvicinamento dell'Africa all'Europa.
Questo movimento del continente africano è iniziato circa cento
milioni di anni fa, è tuttora in atto e ha portato a collisioni e
separazioni di blocchi situati nella morsa di Africa e Europa, con
formazione delle predette montagne e di profondi bacini marini
quali il Mar Tirreno, il mare delle Baleari o il Mar Ionio, il
tutto accompagnato da terremoti e attività vulcanica.
Occorre però tener ben presente che alla scala dei tempi a noi
familiare, cioè alla scala della storia dell'umanità, i fenomeni
sopradescritti sono estremamente lenti, praticamente
impercettibili. Si tratta di processi che si verificano in tempi
geologici, una scala totalmente al di fuori della nostra
immaginazione: uno spostamento verticale o orizzontale di un
millimetro all'anno, praticamente inavvertibile all'occhio umano
(il Monte Bianco o il Gran Sasso crescerebbero di 7-8 cm durante
l'intera vita di un uomo, e della stessa entità sarebbe
l'eventuale avvicinamento dell'Italia alla costa dalmata),
significa un kilometro ogni milione di anni. E i tempi geologici
si misurano a decine e centinaia di milioni di anni! Ecco quindi
che enormi spostamenti o sollevamenti possono verificarsi in tempi
geologici, senza che vi sia alcun bisogno di invocare cataclismi o
altri drammatici eventi.
Possiamo ora concludere dicendo che il processo orogenetico è per
forza di cose posteriore al processo litogenetico e che i due
fenomeni sono di norma (vedremo più avanti le eccezioni) separati
da un lunghissimo lasso di tempo geologico.
|
|
1.3 |
Morfogenesi: formazione del
paesaggio |
|
|
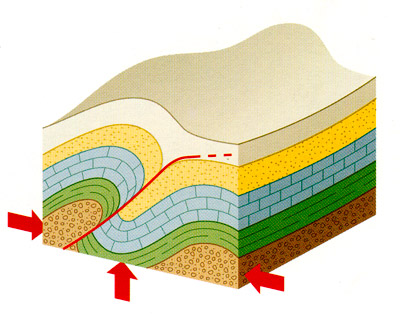 Ciò che
vediamo oggi, tuttavia, non è solo il risultato del sollevamento
dei materiali situati originariamente in fondo al mare e impilati
strato su strato per migliaia di metri. Noi vediamo cime, pareti
rocciose scoscese, profonde incisioni fluviali, vallate, pascoli,
boschi. È evidente dunque che il sollevamento è stato accompagnato
e seguito da erosione e smantellamenti che hanno profondamente
intaccato l'originaria continuità degli strati rocciosi, scolpendo
ardite morfologie e formando un paesaggio vario e articolato. Anche quest'ultima fase, il processo
morfogenetico (dal greco morphe = forma) è il risultato di
vicissitudini assai complesse che possiamo attribuire, nel loro
insieme, agli ultimi due o tre milioni di anni. Ma le Alpi sono
state coperte a più riprese dai ghiacciai che hanno avuto un
grosso impatto nel determinare le forme del paesaggio. L'ultima di
queste glaciazioni, la più importante, è iniziata circa 80000 anni
fa ed è terminata 8.000-10.000 anni fa. Una volta sciolti i
ghiacci che occupavano tutte le vallate alpine, con spessori che
superavano anche i 1500 m, ruscelli, torrenti e fiumi hanno
cominciato a scavare e a trasportare detriti, mentre le pareti
rocciose liberate dalla morsa dei ghiacci cedevano, franando a
valle. Nello stesso tempo, il mare, che durante la glaciazione si
era abbassato di circa 120 m, risaliva invadendo la terra emersa,
scalzando le coste alte e rocciose e formando faraglioni e falesie. L'incomparabile bellezza del paesaggio italiano è
il risultato dell'erosione e della degradazione prodotte dal mare
e dagli agenti atmosferici (acqua, vento, ghiacci) negli ultimi
10000 anni. Ciò che
vediamo oggi, tuttavia, non è solo il risultato del sollevamento
dei materiali situati originariamente in fondo al mare e impilati
strato su strato per migliaia di metri. Noi vediamo cime, pareti
rocciose scoscese, profonde incisioni fluviali, vallate, pascoli,
boschi. È evidente dunque che il sollevamento è stato accompagnato
e seguito da erosione e smantellamenti che hanno profondamente
intaccato l'originaria continuità degli strati rocciosi, scolpendo
ardite morfologie e formando un paesaggio vario e articolato. Anche quest'ultima fase, il processo
morfogenetico (dal greco morphe = forma) è il risultato di
vicissitudini assai complesse che possiamo attribuire, nel loro
insieme, agli ultimi due o tre milioni di anni. Ma le Alpi sono
state coperte a più riprese dai ghiacciai che hanno avuto un
grosso impatto nel determinare le forme del paesaggio. L'ultima di
queste glaciazioni, la più importante, è iniziata circa 80000 anni
fa ed è terminata 8.000-10.000 anni fa. Una volta sciolti i
ghiacci che occupavano tutte le vallate alpine, con spessori che
superavano anche i 1500 m, ruscelli, torrenti e fiumi hanno
cominciato a scavare e a trasportare detriti, mentre le pareti
rocciose liberate dalla morsa dei ghiacci cedevano, franando a
valle. Nello stesso tempo, il mare, che durante la glaciazione si
era abbassato di circa 120 m, risaliva invadendo la terra emersa,
scalzando le coste alte e rocciose e formando faraglioni e falesie. L'incomparabile bellezza del paesaggio italiano è
il risultato dell'erosione e della degradazione prodotte dal mare
e dagli agenti atmosferici (acqua, vento, ghiacci) negli ultimi
10000 anni. |
|
1.4 |
Le tre fasi evolutive di un
paesaggio di montagna |
|
|
Ricapitolando, le montagne sono il risultato di tre differenti
periodi della storia geologica. Quello litogenetico
risale a decine o centinaia di milioni di anni fa ed è
responsabile della formazione delle rocce di cui tali monti sono
costituiti, quello orogenetico, verificatosi invece da alcune
decine a qualche milione di anni fa, ha portato al sollevamento di
tali materiali, mentre quello morfogenetico, recentissimo in
termini geologici, è il diretto responsabile del paesaggio
attuale. Quindi, se uno chiede, per esempio, quando si sono
formati il Monte Bianco o il Gran Sasso, si deve rispondere
distinguendo tra il «quando» si formarono le rocce che li
costituiscono (periodo litogenetico), il «quando» le stesse rocce
furono sollevate e deformate (periodo orogenetico) e il «quando»
esse furono messe a giorno dall'erosione e scolpite fino a formare
le montagne che oggi vediamo. Per quanto riguarda gli esempi
citati sopra, il granito del Monte Bianco si è formato circa 310
milioni di anni fa, ma è stato sollevato alle attuali altezze
soltanto negli ultimi 30^-40 milioni di anni e l'attuale forma del
grande massiccio granitico è il risultato di erosioni e
modellamenti avvenuti negli ultimi 10 000 anni. Analogamente, le
rocce calcaree e dolomiti-che marine che costituiscono il Gran
Sasso si sono originate in gran parte nel Giurassico, tra 200 e
130 milioni di anni fa, ma la deformazione vera e propria e il
sollevamento alle altezze attuali sono assai recenti (ultimi 10
milioni di anni), mentre l'aspetto morfologico attuale con le
ardite pareti e i verdi altopiani è il risultato dei processi
erosivi delle ultime poche migliaia di anni, ivi inclusi il
modellamento dei ghiacci, l'erosione delle acque superficiali,
l'azione del gelo, della neve e dei fenomeni franosi. |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
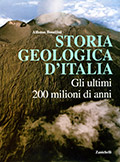 |
Testo e immagini sono state
tratte dal seguente testo:
Autore:
Alfonso Bosellini
Titolo:
Storia Geologica d'Italia gli ultimi 200 milioni di anni.
Editore:
Zanichelli |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|